
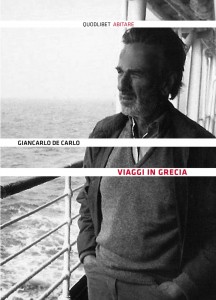 Giancarlo De Carlo è stato uno dei nomi più importanti nella storia dell’architettura non solo italiana nella seconda metà del Ventesimo secolo. Ha insegnato allo Iuav di Venezia ma anche negli Stati Uniti; ha fatto parte di circoli o gruppi di studio quali (unico italiano) il Team X o il Gruppo degli amici di Bocca di Magra, la località dove alcuni fra i più importanti intellettuali italiani fra cui Elio Vittorini e Vittorio Seleni trascorrevano le vacanze; ha progettato opere quali il piano regolatore e gli alloggi studenteschi di Urbino (dove venne chiamato da Carlo Bo), l’area residenziale dell’isola di Mazzorbo (Venezia), il quartiere popolare Matteotti a Terni, Istituti scientifici e universitari a Siena e a Pavia o ville quali quella del pittore Giuseppe Zigaina a Cervignano del Friuli. E ha amato profondamente la Grecia, che ha girato in lungo e in largo prediligendo il Peloponneso e Creta (dove era di stanza, giovane ufficiale di Marina, nella Seconda Guerra mondiale), nella sue vacanze estive dormendo spesso e volentieri in tenda.
Giancarlo De Carlo è stato uno dei nomi più importanti nella storia dell’architettura non solo italiana nella seconda metà del Ventesimo secolo. Ha insegnato allo Iuav di Venezia ma anche negli Stati Uniti; ha fatto parte di circoli o gruppi di studio quali (unico italiano) il Team X o il Gruppo degli amici di Bocca di Magra, la località dove alcuni fra i più importanti intellettuali italiani fra cui Elio Vittorini e Vittorio Seleni trascorrevano le vacanze; ha progettato opere quali il piano regolatore e gli alloggi studenteschi di Urbino (dove venne chiamato da Carlo Bo), l’area residenziale dell’isola di Mazzorbo (Venezia), il quartiere popolare Matteotti a Terni, Istituti scientifici e universitari a Siena e a Pavia o ville quali quella del pittore Giuseppe Zigaina a Cervignano del Friuli. E ha amato profondamente la Grecia, che ha girato in lungo e in largo prediligendo il Peloponneso e Creta (dove era di stanza, giovane ufficiale di Marina, nella Seconda Guerra mondiale), nella sue vacanze estive dormendo spesso e volentieri in tenda.
Prima di morire a 86 anni nel 2005 De Carlo aveva rimesso mano a scritti e appunti raccolti proprio durante le vacanze in Grecia tra gli anni Settanta e gli anni Novanta, accompagnati da schizzi e disegni, senza però riuscire a vederli pubblicati. E’ stata la figlia Anna, nel 2010, a dare alla luce Viaggi in Grecia (Quodlibet-Abitare, pagg. 172, euro 20,00), con la prefazione dell’architetto milanese Stefano Boeri.
“Grecia – spiega Stefano Boeri – non era solo un territorio, ma il nome che De Carlo dava a una geografia mentale ricchissima e ispiratrice di idee di architettura e di città. Grecia era lo stupore continuo per la riscoperta del mito”. Un grande amore, quello legava il grande architetto italiano al Peloponneso e a Creta, ma anche, ad esempio, alla penisola calcidica. Nei suoi viaggi, rigorosamente fuori stagione, De Carlo raccoglieva idee, sviluppava progetti, elaborava gli scritti che sarebbero poi apparsi sulle riviste di architettura. E osservava, anno dopo anno, il cambiare pelle di quel Paese tanto amato: negli anni Settanta ancora selvaggio, verrebbe da dire, ma negli anni Novanta ormai travolto dalle invasioni dei vacanzieri. Si affida alle parole di un generale in pensione proprietario di un terreno nella penisola calcidica nel quale a metà degli anni Settanta De Carlo piantava la sua tenda: “Ci dice – scrive – dei rischi che corre il suo Paese per l’avanzata del turismo di massa, per la caduta di solidarietà e di gusto che la folla anonima e distratta induce nel suo popolo”. Del resto anche la moglie Giuliana è amara, dopo l’ennesimo ritorno nell’amata Grecia trovata ancora una volta pian piano cambiata rispetto anche soltanto all’anno prima: “E’ stato un errore lasciare socchiuse le porte del Paradiso terrestre”.
gusto che la folla anonima e distratta induce nel suo popolo”. Del resto anche la moglie Giuliana è amara, dopo l’ennesimo ritorno nell’amata Grecia trovata ancora una volta pian piano cambiata rispetto anche soltanto all’anno prima: “E’ stato un errore lasciare socchiuse le porte del Paradiso terrestre”.
Scrive ancora De Carlo (peraltro usando uno pseudonimo) nel 1982: “Le stesse donne che cinque anni fa spezzavano il pane appena sfornato e offrivano il primo pezzo al viaggiatore, adesso conducono miserandi negozi chiamati immancabilmente supermarket dove commerciano i cibi in scatola e gli oggetti in plastica più detestabili. I loro mariti, che fino a cinque anni fa discutevano con furore le vicende politiche del loro paese, ora si aggirano come ruffiani alle fermate delle autocorriere per offrire stanze ai turisti che arrivano dalla Germania. In pochi anni il turismo ha prodotto catastrofi irreparabili. L’alibi del benessere legittima misfatti innumerevoli che le due razze, dei locali e dei forestieri, consumano l’una contro l’altra e, tutte e due insieme, nei confronti del luogo dove sorridendosi si dilaniano”.
Sono passati 35 anni da quando scriveva queste parole sulla rivista Spazio e Società. De Carlo è mancato nel 2005: chissà cosa direbbe oggi, che l’unico modello sembra essere diventato Mykonos…
(Guido Barella)





